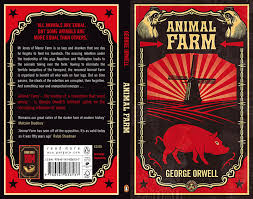Il dibattito politico degli ultimi giorni si è per lo più soffermato sulla determinazione del governo nel realizzare le riforme promesse: stiamo usando la “ruspa” o siamo ancora al “cacciavite”? La discussione ci pare sterile (entrambi sono necessari), mentre sembra più importante capire a quali tra le tante generiche riforme “strutturali” in agenda da anni dovrebbe essere data la priorità. Non solo per le esigenze oggettive del paese, ma soprattutto per comunicare la ferma volontà di cambiare verso. In questo senso, parafrasando La fattoria degli animali si può dire che tutte le riforme strutturali sono ugualmente importanti, ma alcune sono più importanti di altre. Sono quei provvedimenti che, per le ragioni più disparate (incluso il loro valore simbolico), sono più facilmente comprensibili al resto del mondo (dagli investitori esteri ai Commissari europei) e pertanto valgono da affidabili indicatori sulla effettiva forza riformista del governo.
Una guida pratica è quella offerta dalla famigerata lettera della Bce inviata da Trichet e Draghi a Berlusconi nell’agosto del 2011. Nonostante l’iniziale colpo di reni di Monti con le pensioni, la carica del primo esecutivo tecnico si è rapidamente affievolita, e il successivo governo Letta non ha avuto la forza di riprendere il percorso. Lo stato di attuazione delle richieste delle Bce dopo più di tre anni rimane ancora deludente.
La lettera della Bce, non diversamente da tutti i principali rapporti internazionali (per esempio le raccomandazioni della Commissione Ue, dell’Ocse e del Fmi), ruota attorno a tre macro temi: (i) spesa pubblica, (ii) efficienza della pubblica amministrazione e (iii) misure pro-crescita quali liberalizzazioni e riforma del mercato del lavoro. Si tratta di capitoli vasti e complessi, nei quali esigenze tecniche di razionalizzazione si sovrappongono alla legittima discrezionalità rispetto agli indirizzi strategici e organizzativi. All’interno di queste grandi aree, vi sono una serie di interventi puntuali di particolare rilevanza non solo (e in alcuni casi per nulla) per il loro effettivo impatto sulle prospettive di crescita del paese, ma – lo ribadiamo – per la loro natura simbolica.
Innanzitutto c’è la spending review (che sola può consentire la riduzione della pressione fiscale in un contesto di equilibrio dei conti). La sua sorte, dopo l’annunciatoritorno di Cottarelli al Fondo Monetario Internazionale, preoccupa non poco. La lettura ottimista suggerisce che, terminato il suo lavoro, abbia ritenuto esaurito il proprio mandato. La versione pessimista parla invece di un dissidio insanabile tra il tecnico e le sue controparti politiche. La verità sta, realisticamente, nel mezzo: la funzione di Cottarelli non era, e non poteva essere, quella di realizzare i tagli. Piuttosto, egli era incaricato di individuare i possibili interventi. La loro attuazione, e più ancora la riforma di interi capitoli di spesa e dei servizi sottostanti, non è questione tecnica, ma politica. Era inevitabile che il pallino tornasse a Palazzo Chigi. Del resto, la novità di Cottarelli – rispetto ai suoi predecessori, Bondi e Giarda – stava proprio nella distinzione netta tra il ruolo del consulente tecnico e quello del decisore. Di questo bisogna dare atto a Enrico Letta, che seppe evitare l’illusoria visione del Commissario alla revisione della spesa come di un demiurgo a cui delegare il lavoro sporco. Di questo lo stesso Renzi è consapevole, come emerge dai suoi ripetuti richiami alla responsabilità ultima della politica. Desta però qualche preoccupazione la richiesta ai Ministri di individuare possibili tagli per il 3% della spesa di competenza da utilizzare, almeno in parte, per diversi capitoli. Non tutti i settori sono suscettibili di tagli di uguale portata, ma soprattutto così facendo si finirebbe per redistribuire la spesa e non per tagliarla.
A nostro avviso non basta mettere in campo un piano omnicomprensivo dei tagli: occorre trovare degli interventi che siano auto esplicativi e che fungano da cartina al tornasole delle reali intenzioni del governo di incidere nella “palude” della spesa pubblica. Non è un caso se la lettera della Bce cita per esempio l’abolizione delle province, a dispetto della sua ridotta portata in termini di effettivo taglio della spesa (circa 2 miliardi di euro all’anno di minori spese a regime).
Per quanto attiene alla pubblica amministrazione, il comparto che senza dubbio attira la maggiore attenzione è quello della giustizia: il che è comprensibile, alla luce della pessima performance in particolare della giustizia civile. Benché, infatti, in questi giorni il dibattito si sia concentrato su questioni di diritto penale (la prescrizione, le intercettazioni) o sulla magistratura (le ferie giudiziarie e la responsabilità dei giudici) è questo il vero vulnus. Anche qui non servono aggiustamenti micro settoriali, per quanto utili a migliorare la situazione, ma interventi che abbiano vasta portata e un significato comunicativo. Per esempio, prevedere modalità di soluzione in via extragiudiziaria con il pagamento di un’ammenda ridotta per le decine di migliaia di cause per sanzioni amministrative, limitare il ricorso in Cassazione alle sole questioni rilevanti per la salvaguardia o l’uniformità del diritto o relative a diritti fondamentali, incidere sull’organizzazione interna dei tribunali, ecc..
Infine, su liberalizzazioni e mercato del lavoro, preoccupano sempre più i ritardi nell’adozione del Jobs Act che rivelano le difficoltà di Renzi all’interno del Pd. Anche se sappiamo bene che si tratta di un problema che tocca pochi lavoratori, il totem che sarebbe necessario mettere in discussione è quello dell’articolo 18. E ciò non solo per gli effetti più o meno discorsivi di tale previsione, i quali sono oggetto di un intenso dibattito empirico e che talvolta vengono – se non negati – quanto meno messi in discussione alla luce di altre e ancora più pesanti distorsioni (si veda per esempio l’argomento di Marco Leonardi sui salari flessibili). Ma l’articolo 18 è qualcosa che tutti conoscono e capiscono. Se Renzi deve scendere in guerra con i sindacati, meglio farlo sull’art. 18 che su questioni di valenza economica dopotutto limitata.
In più, il vantaggio dei provvedimenti appena citati – che certamente non sono di per sé sufficienti ma vanno intesi come un visibile primo passo – è che rendono molto esplicito il confine tra i riformisti e i conservatori (che si annidano in tutti i partiti). Perché quasi chirurgicamente vanno a colpire gli interessi di gruppi che, in questi anni, hanno influenzato pesantemente il processo di decision making ottenendo rilevanti rendite di posizione: dalle burocrazie ai sindacati fino alle imprese protette e ai “furbetti” che hanno tutto da guadagnare dalle inefficienze della giustizia. Diderot diceva “non basta fare il bene, bisogna farlo bene”. Noi aggiungeremmo che occorre anche farlo vedere.
Carlo Stagnaro e Alberto Saravalle